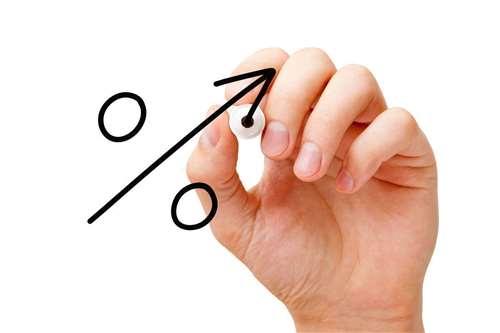- Altri marchi del Gruppo:
- Trovaprezzi
- Prestitionline.it
- Segugio.it
Spazi privati ad uso pubblico
La proprietà privata di un'area non esclude il suo uso pubblico quando questo avvenga da soggetti titolari di un interesse pubblico di carattere generale. Si pensi alla servitù di passaggio, alla dicatio ad patriam, e all'usucapione. Chi si occupa della manutenzione del bene?

Spazi privati ad uso pubblico
La proprietà privata di un'area non esclude l'uso pubblico della stessa, infatti, un'area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un interesse pubblico di carattere generale.
Pertanto per area privata ad uso pubblico si intende l’apertura alla circolazione di un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso all'area da parte del pubblico (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5414 del 07.05.1992).
Come si sottopone un bene privato ad uso pubblico?
Affinchè un’area possa ritenersi sottoposta ad un uso pubblico è necessario, oltrechè l’intrinseca idoneità del bene, che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico e generale interesse. Ad esempio, se si è proprietari di una limitata porzione privata di via, ciò non impedisce la natura complessivamente pubblica della strada e soprattutto non vale ad escludere o mettere in discussione l’utilizzazione ad un uso pubblico indiscriminato della strada stessa.
Un bene di proprietà di un soggetto privato può essere sottoposto ad uso della collettività, per qualsivoglia tipo di necessità specifica. Si pensi ad esempio alla servitù di passaggio per una strada privata, alla dicatio ad patriam, alla convenzione edilizia, e all’usucapione.
Analizziamole una ad una:
a) Servitù: la servitù di passaggio è una limitazione imposta a un fondo (detto fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (detto fondo dominante) che appartiene a un altro proprietario. Un caso tipico è quello di un terreno precluso alla pubblica via. Il proprietario, per potere entrare e uscire dal suo fondo, è costretto all’attraversamento del terreno di un vicino, sul quale il giudice o le parti contrattualmente imporranno una servitù di passaggio.
b) Dicatio ad patriam: ossia il modo di costituzione di una servitù di uso pubblico mediante il comportamento del proprietario che mette un proprio bene a disposizione della collettività.
c) Convezione edilizia: un accordo tra imprese costruttrici private e Comuni.
d) Usucapione ventennale: modo di acquisto della proprietà di una cosa o di altro diritto reale di godimento su di essa, mediante il possesso della cosa stessa per un periodo di tempo stabilito dalla legge.
I problemi nella gestione del bene privato ad uso pubblico
Una volta che un bene di proprietà privata è assoggettato ad un uso di pubblica utilità, possono sorgere problematiche relative alla gestione del medesimo bene: problemi di costi, spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Chi deve sostenere i costi della messa in sicurezza?
Dato che il bene è privato ma l’utilizzo è di pubblica utilità, una volta individuati i criteri che permettono di definire titolarità e funzione del bene stesso (come ad esempio una strada), si possono individuare i soggetti cui spettano la cura e la manutenzione, nonché le forme in cui questo incombente viene esercitato.
Analizziamo il caso specifico della strada di proprietà privata. Ancora oggi per la loro gestione la normativa specifica del nostro ordinamento è affidata al D.L.Lgt. n. 1446/1918 (tuttora vigente per effetto del d.lgs. n. 179/2009 che lo ha espunto dall’elenco delle abrogazioni allegato al d.I. n. 200/2008, conv. in legge n. 9/2009). Tale provvedimento disciplina la possibilità, per gli utenti di tali strade, di costituirsi in consorzi per consentirne la gestione, manutenzione e ricostruzione con una ripartizione di costi tra i soggetti consorziati. Il procedimento di costituzione e la natura stessa del Consorzio sono differenziati a seconda che la via privata sia soggetta, o meno, a pubblico transito.
Per il caso di vie private non destinate al pubblico transito, la costituzione del consorzio è facoltativa (art. 1 D.L.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446); Trattandosi di strada privata non destinata all'uso pubblico, il Comune non è tenuto ad una partecipazione economica nel Consorzio, ma ha la facoltà di concorrere alle spese solo per opere di sistemazione o ricostruzione (esclusa quindi la manutenzione), in misura non eccedente il quinto della spesa.
Il senso dell'istituto è in sostanza quello di coinvolgere nella gestione della strada anche quei soggetti che, pur non proprietari, la utilizzano. Evidentemente, se gli utilizzatori coincidono con i proprietari, o addirittura si tratta di un'unica persona, la complessa procedura di costituzione del consorzio, facoltativa, non ha ragion d'essere. In tal caso la manutenzione della strada ricadrà esclusivamente sui proprietari della stessa.
Se invece la strada privata è soggetta al pubblico transito la costituzione di consorzio per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione della via vicinale è obbligatoria (art. 14 L. 12 febbraio 1958, n. 126).
Si precisa inoltre che il Comune, in questi casi, è obbligatoriamente tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle vie vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto alla metà della spesa, secondo il grado di importanza della strada. Il Comune partecipa altresì alle decisioni del consorzio, con voto proporzionale alla misura del concorso.
Va infine ricordato che i consorzi per la gestione di strade vicinali soggette a uso pubblico assumono inoltre natura di enti pubblici e ad essi si applicano le norme sulla contrattualistica pubblica, a differenza dei consorzi per la gestione di strade ad uso privato, che hanno natura di soggetti privati (Cass. civ. Sez. I, 13 ottobre 2014, n. 21593).
Articoli correlati